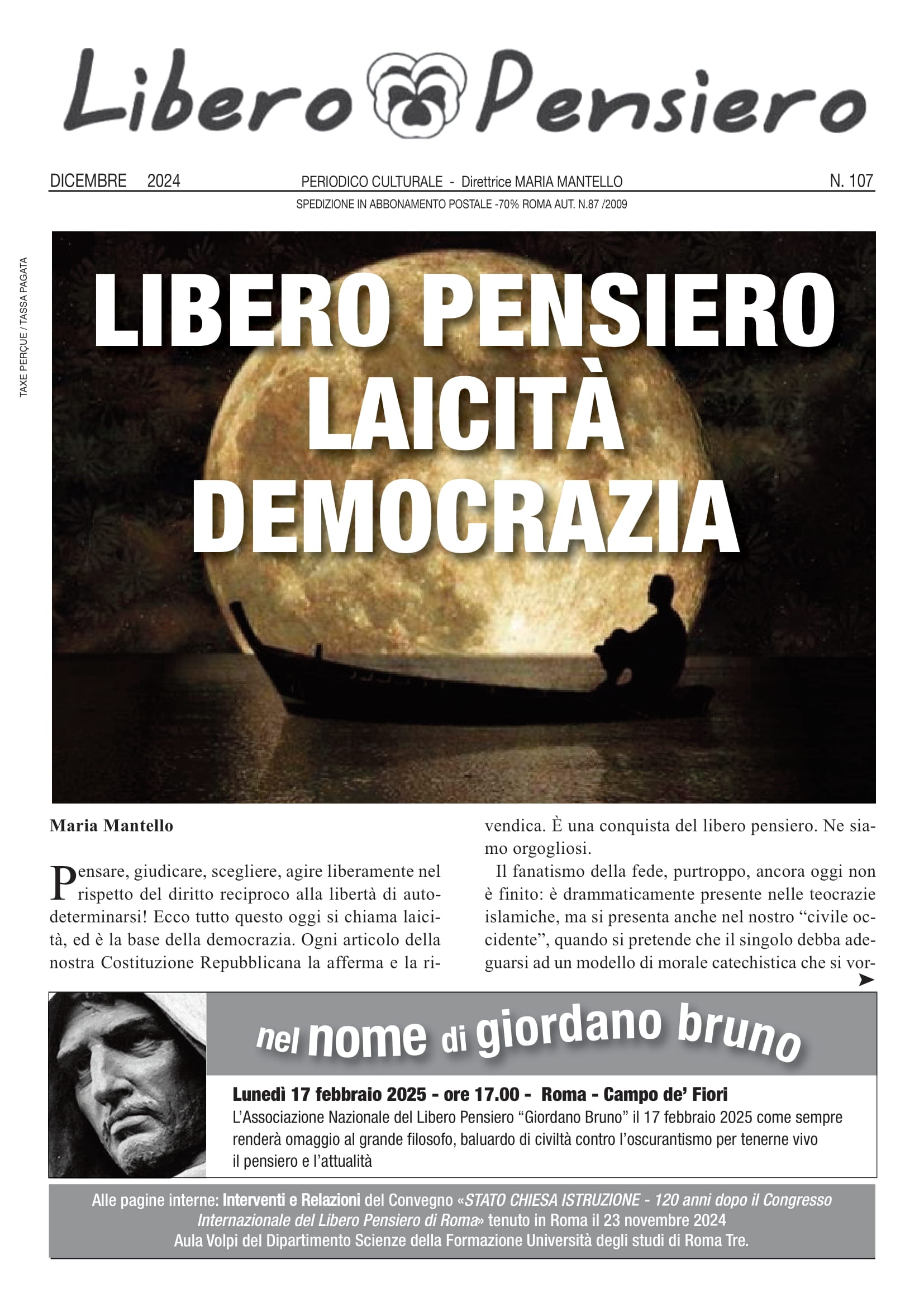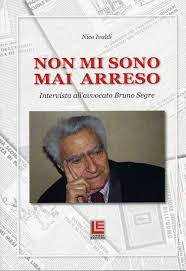|
|
|
Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
Intervista a Bruno Segre
“Bruno Segre, La Resistenza
della Non violenza” di Maurizio
Pagliassotti e Marco Vittone, Il Manifesto 26/4/
2017
Nel suo studio settecentesco è
stratificato il secolo breve. Qui lavora Bruno
Segre, partigiano e avvocato. Novantotto anni di
vita spesi come in un romanzo, tra pallottole
bloccate da un portasigarette in metallo, alla
Torino di Natalia Ginzburg e di Cesare Pavese, alle
primissime cause in difesa degli obiettori di
coscienza fino alla battaglia civile per il
divorzio. Bruno Segre nella sua lunga vita ha
vissuto tutto. Partiamo da Torino, e dal suo
cambiamento nel corso dei decenni. Un immenso cambiamento. Ricordo
una città piccola e gentile, con le lampade a gas
nelle vie del centro, poi diventata grande e
caotica, che ora torna ad essere più attraente,
simile a quella che ho vissuto da ragazzo. Cambiano
la cultura, nelle città come nella morale: per
baciare una ragazza qui a Torino ci volevano mesi,
corteggiamenti serrati. Ora, non è più così: tutto è
divenuto più veloce. Una città cosmopolita, lo è
sempre stata. Cosmopolita e industriosa, che ha
fatto del lavoro un primato morale. Io ce l’avevo
con la Fiat: i benefici del lavoro operaio li hanno
avuti gli Agnelli, che hanno fatto ben poco per
accogliere i nuovi lavoratori che giungevano dal
Sud, e non solo, nella seconda metà del Novecento.
Le spese per rendere la vita civile a queste persone
(trasporti, ospedali, scuole, ecc.) se le accollò il
Comune di Torino. E gli Agnelli chi sono stati? I padroni della città. Cosa furono le leggi razziali a
Torino? Mi colpì l’indifferenza della
gente: gli ebrei in Italia erano circa quarantamila,
molti occupavano cattedre universitarie, alcuni
erano filantropi che avevano gratificato con
donazioni le Istituzioni cittadine. Ci fu una sorta
di umiliazione collettiva. Una celebre caffetteria
del centro espose il cartello: «Qui gli ebrei non
sono graditi». Molte ditte dovettero chiudere o
cambiare denominazione. Constatai un diffuso
egoismo, la gente approfittava dell’emarginazione e
discriminazione degli ebrei per prendere il loro
posto. Cosa ancor peggiore fu l’espulsione dalle
scuole. Quando furono attuate le normative
antisemite, gli studenti ebrei all’università
potevano terminare gli studi (io mi laureai con
Einaudi) ma non proseguire altri corsi universitari.
Viceversa gli ebrei tedeschi dovettero cessare
subito il corso di studi senza laurearsi. Ciò palesa
la sudditanza del fascismo agli ordini del nazismo.
I fascisti emergevano per ignoranza e stupidità.
Molti ebrei che non sapevano di essere tali, lo
scoprirono solo quando furono perseguitati. Perché entrò nella Resistenza? Sono sempre stato antifascista:
da ragazzo fui cacciato dall’aula scolastica perché
mi dichiaravo contro la guerra in Etiopia.
Nell’inverno del ’42 sono stato tre mesi incarcerato
alle Nuove perché accusato di disfattismo. Il momento dell’arresto? Nel ‘42, avevo scritto
l’unico articolo antirazzista apparso in Italia
sulla rivista torinese L’igiene e la vita,
subito soppressa. Nelle carceri Nuove la vita era
terribile, quell’inverno fu il più freddo del
secolo. I vetri delle celle erano rotti dai
bombardamenti. Fu il “generale inverno” a bloccare
l’avanzata dei carri armati tedeschi in territorio
russo. Ci trattavano come animali, alla domenica ci
davano pezzi di carne tratti da un sacco con la
forchetta. Nel 1944 mi spararono addosso. Finii in
via Asti, volevano sapere come avevo avuto un
lasciapassare tedesco. Prima però mi sporsero su una
finestra, e urlavano: «O parli o ti buttiamo giù».
Non parlai, sotto c’era gente che passeggiava.
Inoltre ignoravo chi, in sede clandestina, mi aveva
donato il documento. Cosa fu la fine della guerra? La gente ballava per le strade,
angloamericani e francesi vendevano le loro
pubblicazioni di propaganda. C’erano grandi speranze
di rinnovamento. Io volevo uccidere l’ex prete
fascista Gino Sottochiesa che aveva scritto sui
giornali nazifascisti articoli contro gli ebrei
fomentando la propaganda antisemita. Per fortuna non
lo trovai. S’era nascosto in un convento. Chi si poteva incontrare a
Torino negli anni ’50? Presentai il libro di Pimo
Levi, La tregua: era un personaggio solitario,
malinconico. Ho frequentato Carlo Levi, Cesare
Pavese e Leone Ginzburg: Pavese diceva che Carlo
Levi era un po’ esibizionista. Natalia Ginzburg era
mia compagna di classe al liceo Alfieri: a scuola
scriveva componimenti erotici. Spiccava per la sua
intelligenza. Perché ha iniziato a difendere
gli obiettori di coscienza? Conobbi Aldo Capitini alla fine anni Quaranta. Mi fece conoscere il giovane sardo, Pietro Pinna, che aveva rifiutato di impugnare le armi e io lo difesi il 31 agosto 1949 dinnanzi al Tribunale Militare di Torino. Fu un processo clamoroso, vennero giornalisti dall’estero. Da allora ho difeso centinaia di obiettori in tutti i Tribunali Militari d’Italia, perché mi convinsi che la nonviolenza è forza non debolezza. Lo stesso ho fatto con i giudizi per il divorzio. Oggi è tutto normale. La Storia ha bisogno, a volte, di punti di rottura.
|
|||||||||||